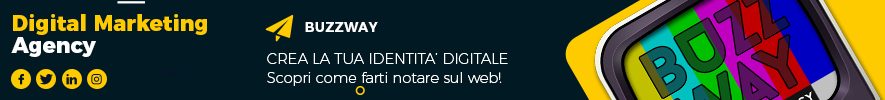All’interno del ciclo di incontri “I popoli fioriscono”, organizzato dall’assessore Antonio Scialpi, l’incontro con lo scrittore e poeta iracheno Jabbar Yassin Hussin è uno dei momenti più alti dell’inverno martinese. Dopo Malalai Joya, ex parlamentare afgana che lotta per i diritti delle donne, è il turno di un altro esiliato.
Jabbar, che più volte è passato qui a Martina Franca, ha parlato di sé e della sua storia, del suo esilio. A vederlo così, con i suoi capelli e la barba bianca, col suo volto che ha delle occhiaie un po’ scure, qualche ruga e una espressione di infinita tenerezza, non si direbbe una persona pericolosa: eppure doveva esserlo, visto che se non fosse vissuto per anni all’estero, in Francia, sarebbe probabilmente stato torturato o ucciso in Iraq, sotto Saddam Hussein, lo stesso Saddam del quale dopo la caduta del regime si è trovata una lettera nella quale si cercavano ossessivamente tutte le informazioni possibili su di lui, bollandolo come pericoloso avversario del regime.
Chi è allora Jabbar? Come può un poeta essere pericoloso? Nato nel 1952 a Baghdad, va in esilio scappando fortunosamente per evitare le persecuzioni di Saddam contro gli oppositori, trasferendosi in Francia. Abbandona le sorelle, la madre che piangeva, il padre che singhiozzava rivolto verso il muro e il nonno, che non rivedrà mai più, con le lacrime che gli bagnavano la barba. Nelle sue poesie e nei suoi scritti Jabbar è quasi ossessionato da un argomento: la memoria. Ha un’ottima memoria e ricorda quando aveva cinque anni, quando suo fratello mise in una cassa di ferro dei libri che erano diventato proibiti, come una raccolta di poesie di Majakovskij o L’origine della Famiglia di Engels e la sotterrò nel giardino. Jabbar ricorda tutto questo e lo racconta, in libertà, sfidando l’ottusità. La stessa ottusità che deriva dall’ignoranza forzata e che ha spinto dei fanatici del regime nel 2003 a urlare armati di Kalashnikov nelle piazze “Saddam è la nostra anima e noi moriremo per lui”, la paura che censura non solo gli scritti ma anche i pensieri.
L’esilio, ha raccontato, è l’esperienza più dolorosa che si possa provare; specialmente quando, ritornando in patria dopo anni e anni di lontananza la si vede trasformata, diversa, estranea alla memoria che ne avevamo serbato; e si viene additati in quella che si crede come la propria casa come degli stranieri, degli estranei. Dopo aver mangiato il pane amaro dell’esilio chi torna è condannato a vivere quell’incubo che tormentava, nei lager, i prigionieri come Primo Levi: di tornare un giorno nella propria casa, parlare, raccontare tutto e trovare un muro di ostinata indifferenza: «Allora» raccontava Primo Levi «nasce in me una pena desolata: è dolore allo stato puro».
Daniele Milazzo